CRONACHE ISTRIANE Un naturalista nelle saline di Capodistria - GIUSTINO POLI - foto
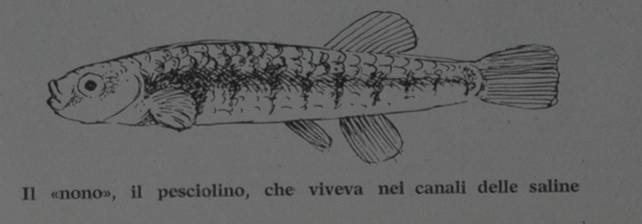
foto
Didascalie:
Il «nono», il pesciolino, che viveva nel canali delle saline
L'alga rossa, che prosperava sotto il ponte di Semedella (Ceranium radiculosum)
L'Artemia salina, il curioso piccolo gamberetto dalle proprietà singolari (5-10 mm.)
L'uomo moderno, quello che, come noi, vive accalcato in mezzo al cemento e all'asfalto della città, ha penduto quasi completamente il contatto con la natura, per cui acquista il sapore di una gradita riscoperta tutto de che lo riporta ai tempi in cui tra il vivere quotidiano e il mondo naturale non v'era alcun diaframma.
E' il caso di un libretto di non molte pagine capitatoci recentemente tra le mani, un'operetta che reputiamo unica nel suo genere, del dott. Adolf Steuer, naturalista e libero docente presso l'Università di Innsbruck («Biologischee Skizzenbuch fur die Adria», edito nel 1910 da B. G. Teubner, stampatore e editore in Lipsia e Berlino).
V'è veramente una ragione di più, che ci ha fatto apprezzare grandemente quanto ha scritto lo Steuer: il nostalgico riandare all'epoca della fanciullezza, quando eravamo soliti vagare sugli argini delle saline di Capodistria, ormai già abbandonate, tra cielo e mare, e l'amore per la nostra terra, che traspare dalle pagine dell'autore oltremontano, il quale intercala nel testo tedesco molte parole in italiano e financo i versi vernacoli di una nota canzoncina.
Ci riferiamo in modo particolare al capitolo III intitolato, appunto, «Nelle saline», tra le cui righe abbiamo spaziato con interesse.
«Ai piedi delle vigne dolcemente digradanti, tra il verde fogliame delle quali occhieggia qua e là il rosso fuoco delle mele, brillano sotto i chiari raggi estivi del sole le superfici delle saline istriane, biancheggianti come la neve. Sull'orizzonte una pennellata di azzurro profondo, il mare, e, sopra, il cielo senza nubi del sud...»
L'autore è rimasto evidentemente incantato dallo spettacolo, tanto da distrarsi richiamato infine dalla guardia di finanza, che gli chiedeva, in un guazzabuglio d'italiano, slavo e tedesco strascicato, di esibire il permesso di passaggio... «Prego, gospod, chaben Sie Erlaubnis?» Il prof. Steuer ricordava allora al lettore che, in Austria, il sale era un noto genere di monopolio, che poteva rendere allo Stato anche 5 milioni e mezzo di corone all'anno per quanto riguardava le sole saline istriane, che occupavano una estensione di 883 ettari, 628 dei quali appartenenti a Pirano e 225 a Capodistria.
Dopo una breve ma precisa descrizione del sistema di salificazione in atto nelle nostre parti, l'autore accennava a quella particolare acqua, che si trovava nelle due.profonde buche sistemate negli an goli superiori della prima delle superfici salifere, una specie di ranno estremamente interessante per il mondo degli organismi caratteristici delle saline, contenente in forte concentrazione diverse specie di sali di magnesio, sodio e potassio (solfati, cloruri, bromuri), reso di colore rossastro per la presenza della «Dunalíella salina», un curioso microorganismo pur esso presente in forte concentrazione. I flutti del mare sono ricchi anche di sostanze organiche, resti di animali, che si raccolgono sul fondale colorando l'argilla di nero pece, sì da farla sembrare catramosa. Grande era la quantità degli animali marini, che, morendo, si depositavano sul fondo dei canali e dei fossati delle saline, concimandolo, per così dire, e rendendo possibile lo sviluppo di altre forme di vita vegetale o animale adatte all'ambiente altamente salino.
Dalla strada di Semedella, che segnava come una diga il limite verso il mare aperto delle saline, era agevole penetrare con lo sguardo sotto la superficie dell'acqua bassa e limpida. Più facilmente che altrove era dato, là, di cogliere interessanti spettacoli, come personalmente ricordiamo. Nello stretto passaggio praticato sotto il ponte, che dava sullo specchio d'acqua della Porporella, il prof. Steuer individuava una interessante alga rossa, il «Ceranium radiculosum», che era copiosa nelle zone lagunari, tra Grado e Venezia, nelle acque dolcificate alle foci dei fiumi, mentre qui, caso raro e non riscontrato in altri posti dell'Istria, viveva bene nell'acqua salata. Ai piedi dei massi murari prosperava una colonia di magnifici anemoni di mare («Anemonia sulcata») mentre più avanti, sulla sabbia chiara e liscia, spiccavano delle attinie («Cerianthue membranaceus») la cui variopinta corona di tentacoli, al contatto di un
corpo estraneo, si ritirava prestamente nell'abitacolo mucoso. Un granchio si affrettava per i fatti suoi senza degnarsi del gambero eremita, che gli zoppicava vicino, mentre un pesce dal muso ricagnato («Blenniue tentacularis», della famiglia delle bavose che noi chiamavamo «galletto») schizzava via saettando sotto una pietra, sulla quale si spingeva avanti faticosamente con i suoi innumerevoli peduncoli pompanti una stella del mare («Astropeclen spinulosus»). Completavano il quadro della fauna due piccole lumache, la piatta «Cyclonassa neritea» e la «Nassa reticulata» dal guscio conico, appena degna di considerazione per il fatto che madre natura aveva l'abitudine di tregiare la sua casa con un giardino in miniatura di graziosi polipetti. E' una scenetta vivacemente descritta dal naturalista, che ce la presenta, divertito, come su di un piccolo palcoscenico. Avanzando verso le saline vere e proprie si manifestava sempre più l'impoverimento delle specie animali e vegetali. Nei canali più grandi prosperavano ancora le alghe marine a foglia stretta, tra le quali non mancavano le conchiglie del «Cardium», i granchi nonché, in buona quantità, la «Lebiae calaritana», un pesciolino grazioso detto volgarmente «nono», creduto velenoso secondo quanto dice lo Steuer (non sappiamo da chi egli abbia raccolta tale diceria in quanto i «noni» costituivano un noto piatto popolare). I pesciolini vagavano per i canali pascendosi di una cert'alga grigio bluastra («Lyngbya» e «Spirulina»), che cresceva negli anfratti del fondo. Disturbati, fuggivano a casaccio a branchi compatti battendo disperatamente l'acqua con le loro 'mille code sì da produrre un rumore come di pioggia.
Le zone dove l'acqua stagnava erano di dominio delle zanzare, dei ditteri per dirla pulitamente, di cui venivano individuate 5 specie, alcune delle quali tipiche delle saline («Halmopota salinarium» e «Triochladius salinarius»). Naturalmente tali noiosi insetti non potevano mancare e, a sera, arrivavano a nuvoli anche sulla città e la gente cercava di difendersi con «fumenti», catturando poi, al mattino,
segue
